Giulia Tofana, il suo nome è scolpito nella storia come quello di una donna che, nell'ombra della sua epoca, ha scritto un capitolo doloroso e, insieme, coraggioso. La sua vicenda affonda le radici in un’epoca in cui le donne erano, più che mai, merce di scambio nelle mani di padri, mariti e società, relegate a ruoli marginali, privi di diritti e di voce. La sua storia è quella di una sopravvivenza non solo fisica, ma anche emotiva e psicologica, in un mondo che le voleva silenziose, obbedienti e sottomesse.
Giulia nasce, si dice, tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600 a Palermo, città che all'epoca, sotto il dominio spagnolo, viveva il suo massimo splendore. Eppure, al di là della bellezza dei palazzi barocchi e delle sfarzose corti nobiliari, si celava un'altra realtà, fatta di sofferenza, disuguaglianza e repressione per le donne. A quel tempo, l'idea di un matrimonio non era un atto di amore, ma un’alleanza sociale e politica, e per le donne, troppo spesso, un destino tragico.
Era un'epoca in cui il matrimonio significava la subordinazione totale: le donne erano confinate a una vita domestica, con pochi diritti e molte, troppe, sofferenze. In questa cornice si inserisce la figura di Giulia Tofana, una donna che, pur essendo anch'essa prigioniera di quel sistema, riuscì a diventare una delle figure più enigmatiche e, in qualche modo, liberatorie della sua epoca.
Giulia non fu solo una persona che creò un veleno letale, ma una sorta di “ultima spiaggia” per tutte quelle donne che, schiacciate dalla violenza e dalla repressione, non avevano alcuna via di fuga. Le leggi dell’epoca non proteggevano le donne maltrattate: il divorzio era impensabile, l'infedeltà del marito era considerata peccato, ma la violenza domestica, fisica ed emotiva, era considerata una “norma”. Non c’era spazio per l’autoaffermazione, non c’era rifugio per chi voleva scappare dalla gabbia di un matrimonio violento. Le donne non avevano il diritto di decidere, né della loro vita, né del loro corpo.
Giulia Tofana, in questo scenario, si erge come una figura tragica e salvifica. Un impasto di bellezza prorompente, astuzia, crudeltà e totale assenza di scrupoli , si dice che, inizialmente, fosse una preparatrice di cosmetici e farmacista, ma la sua vera notorietà è legata a un rimedio che divenne il suo marchio di fabbrica: l’acqua di Tofana. Si trattava di una pozione che, se somministrata in piccole dosi, provocava la morte in modo lento e apparentemente naturale, senza destare sospetti. Una via di fuga per le donne che non avevano altre opzioni, che vivevano in una condizione di costante paura e subivano abusi da parte dei mariti.
La ricetta non è nota con precisione: alcune fonti parlano di un misto di anidride arseniosa, limatura di piombo e antimonio (o belladonna) messo a bollire per circa un’ ora in una pignatta ben sigillata; dopo il raffreddamento, il liquido veniva travasato in piccole bottigliette. Non sono note le quantità degli ingredienti utilizzati ma l’efficacia del prodotto era garantita: incolore, insapore, privo di odore, erano sufficienti poche gocce negli alimenti e nelle bevande quotidiane per provocare una morte senza grosse sofferenze e senza sintomi che potessero essere ricondotti all’avvelenamento. Sembrava una banale sindrome influenzale che però uccideva in una decina di giorni, mantenendo roseo il colorito della persona defunta.
Pare che il prezzo di una bottiglietta da mezzo quarto fosse di cento doppie d’oro e fu così che Giulia divenne in poco tempo molto ricca.
Intorno al 1640 si trasferì nel continente perché, dopo la morte di un ricco mercante di Genova, tal Ippolito Larcari, iniziarono a circolare sospetti su un suo probabile coinvolgimento.
La morte di Lercari era stata subito attribuita ad un veleno poiché l’avvelenatore, Luciano Spadafora, aveva somministrato una dose ben superiore a quella prescritta, forse pensando di accelerare la fine del malcapitato, ma così facendo le tracce della sostanza velenosa divennero subito evidenti. Durante il processo a suo carico, emersero inevitabilmente i legami con la presunta “fattucchiera”, costringendola alla fuga.
Da Palermo a Napoli a Roma, con la figlia (o sorella di latte) Girolama Spana, Giulia affiancò alla produzione dell’acqua tofana l’attività di sensale di matrimoni «e anche di fattucchiera in quanto s’intendeva di fisonomia», entrando ben presto negli ambienti “bene” della città eterna grazie alla sua avvenenza e spregiudicatezza. Imparò a leggere e scrivere e adottò uno stile di vita da dama di nobile rango. Tra i suoi amanti vi furono anche diversi esponenti dell’alto clero e uno in particolare, padre Girolamo di Sant’Agnese, diventò suo fidato collaboratore, preziosissimo poiché insospettabile e con molte amicizie utili tra gli speziali che riuscivano a procurare senza difficoltà, né troppe domande, l’arsenico e le materie prime necessarie alla produzione del veleno.
A Roma trovò un ambiente estremamente favorevole al suo commercio soprattutto tra le tante donne costrette a una vita d’inferno accanto a mariti violenti, spesso ubriachi o parecchio più vecchi di loro; molte la consultavano talvolta per abortire o per avere sostanze contraccettive e poi magari tornavano a casa con la magica fiaschetta.
Dopo circa una decina d’anni di attività, due incidenti posero fine alla carriera di Giulia. Una sua cliente, la contessa di Ceri, evidentemente troppo ansiosa di liberarsi del marito e ignorando le prescrizioni, gli aveva somministrato tutto il flacone in un’unica soluzione causandone naturalmente la morte istantanea, come era già avvenuto al genovese Lercari.
Alla denuncia dei parenti della vittima si aggiunse anche quella di un marito sopravvissuto ad un tentato avvelenamento e ben presto le autorità arrestarono la responsabile. Non bisogna dimenticare che in quel periodo il Tribunale dell’Inquisizione faceva la parte del leone nei processi a imputati/e in odore di stregoneria e sospettati/e di pratiche occulte e anche Giulia finì nella stanza delle torture dove confessò di aver venduto, nella sola Roma, dosi di veleno sufficienti a uccidere circa seicento uomini tra il 1633 e il 1651.
A questo punto però le versioni sulla sorte di Tofana sono discordi: la maggior parte di esse sostiene la tesi che Giulia fu impiccata in Campo de’ Fiori nel 1659, nello stesso luogo dove era stato mandato al rogo Giordano Bruno. La medesima sorte sarebbe toccata a Girolama e a numerose donne giudicate colpevoli di aver avvelenato i mariti.
Secondo un’altra tesi Giulia sarebbe riuscita a far perdere le sue tracce dopo essere stata processata e assolta grazie all’intervento autorevole del suo amante, padre Girolamo. La tesi difensiva era basata sull’assunto che il prodotto incriminato era efficace per la cura della pelle ed era stato messo in commercio con quello scopo; la produttrice non poteva essere responsabile di usi diversi e non opportuni dello stesso.
Giulia è passata alla storia quindi per la creazione di un veleno letale, , che divenne uno strumento di liberazione tragica per molte donne costrette a vivere sotto il giogo di matrimoni violenti e oppressivi. Questo veleno, prodotto con una grande astuzia, è uno degli aspetti più misteriosi e inquietanti della sua figura, che ha fatto di lei una leggenda oscura e un simbolo di resistenza silenziosa contro l'oppressione patriarcale.
Somministrato in piccole dosi, l'arsenico agiva lentamente, inducendo sintomi che sembravano comuni malattie come vomito, diarrea e debolezza, rendendo difficile per i medici diagnosticare la causa della morte. In questo modo, la morte risultava apparentemente naturale, e la vittima poteva morire senza destare sospetti, proteggendo così la donna che lo somministrava dal rischio di essere accusata di omicidio.
Il veleno veniva confezionato in piccole bottiglie, e Giulia Tofana, che probabilmente lo preparava personalmente, lo distribuiva alle donne che si rivolgevano a lei. Le clienti di Giulia erano in gran parte donne che vivevano matrimoni brutali, spesso con mariti violenti o abusanti, e che vedevano in quella piccola bottiglia la loro unica via di fuga. L’acqua di Tofana, una soluzione alchemica che mescolava arsenico, belladonna e altre sostanze velenose, veniva venduta in modo discreto, spesso sotto forma di cosmetici o liquidi apparentemente innocui, come lozioni per la pelle o tonici per il viso.
Si racconta che Giulia non fosse la sola a produrre il veleno, ma che avesse una rete di collaboratori e clienti che lo distribuissero sotto copertura, a testimonianza della diffusione di questa "soluzione finale" tra le donne dell'epoca. In molti casi, le donne che usavano l’acqua di Tofana lo facevano con l’accordo che le sue dosi fossero somministrate lentamente, in modo da non destare sospetti. La morte dei mariti avveniva quindi senza segni evidenti di violenza, e le cause naturali come le malattie venivano frequentemente citate come motivazioni.
La pozione non era destinata solo a uccidere, ma era vista anche come un atto di autodifesa. Un atto estremo di liberazione per quelle donne che, vittime di abusi psicologici, fisici ed economici, non avevano altro modo per sottrarsi alla tirannia dei loro mariti. Per queste donne, l’acqua di Tofana non era solo un veleno, ma una risposta disperata a una condizione di vita che non offriva altra via di scampo.
Il veleno divenne celebre, ma anche pericoloso. Le autorità si accorsero presto della sua diffusione e iniziarono a investigare su queste misteriose morti di uomini sposati, che sembravano accadere senza spiegazioni apparenti. Nel 1659, la rete di distribuzione del veleno fu smascherata, e Giulia Tofana, arrestata e sottoposta a tortura, confessò la sua responsabilità nella creazione e diffusione dell’acqua di Tofana. Nonostante le torture, Giulia non tradì mai le altre donne coinvolte nel traffico del veleno. Fu giustiziata, ma la leggenda che circonda la sua figura rimase viva anche dopo la sua morte.
Gli storici non sono concordi sul numero preciso di vittime causate dall'acqua di Tofana, ma si stima che centinaia di donne abbiano fatto uso di questa pozione letale. In alcune versioni della storia, si dice che Giulia abbia creato il veleno come una sorta di “mestiere” per sé stessa, ma non mancano anche interpretazioni che la vedono come un' eroina, che offriva alle donne un’ultima opportunità di sopravvivenza in un mondo che non aveva misericordia per loro.
Oggi, l’acqua di Tofana non è solo un simbolo di disperazione, ma anche una testimonianza storica di come la conoscenza, la creatività e la sopravvivenza possano intersecarsi in modi oscuri e tragici. Il veleno non è mai stato visto come una "soluzione giusta", ma come l'ultimo atto di una donna che, pur di non soccombere, ha scelto la via più oscura di tutte. Con Giulia Tofana, la storia ci parla di un'umanità costretta a confrontarsi con le proprie leggi e la propria brutalità, e di come, a volte, il desiderio di libertà possa assumere forme tragiche e complesse.
La creazione di quest'arma micidiale non fu un atto di vendetta, ma di disperazione, una risposta al dolore e alla sofferenza di tante donne che, per troppo tempo, erano state ignorate e abusate. Giulia Tofana non fece altro che offrire loro una speranza, seppur estrema e drammatica, di salvezza. Il veleno non era solo una soluzione fisica, ma un atto simbolico: un atto di resistenza contro un sistema che aveva imposto la morte sociale a tutte quelle donne che, come tante altre prima di loro, avevano cercato di affermare la propria umanità.
Ciò che Giulia Tofana rappresenta non è solo l’ingegno di una donna che ha saputo sfruttare le conoscenze alchemiche del suo tempo per creare qualcosa di fatale, ma soprattutto la sua capacità di leggere la sofferenza di chi le stava intorno e di rispondere con una possibilità, anche se tragica, di liberazione. La sua pozione non offriva giustizia, non restituiva dignità, ma faceva in modo che almeno le donne potessero sentirsi, per un attimo, padroni del proprio destino.
Le donne che si rivolgevano a Giulia non lo facevano per crudeltà, ma per un disperato bisogno di sopravvivenza. Non avevano alternative, non c’erano istituzioni che le proteggessero, non c’erano leggi che difendessero i loro diritti. La scelta di Giulia, dunque, non fu una questione morale, ma una risposta a una condizione disumana. Eppure, nonostante la sua azione sia stata vista come un gesto di ribellione, la condanna che colpì Giulia fu severissima: alla fine della sua carriera, nel 1659, la sua rete di complicità venne scoperta, e Giulia Tofana fu arrestata, torturata e giustiziata.
La sua morte, però, non cancellò l'importanza della sua esistenza, né l'impatto che ebbe sulla vita di quelle donne che riuscirono, seppur per poco, a evadere dalle catene invisibili di una società patriarcale. La leggenda di Giulia Tofana è un monito e un racconto che parla di disperazione, ma anche di forza e di resistenza. In un’epoca di buio totale, Giulia rappresentò una luce, anche se in forma di veleno.
Oggi, riflettendo sulla sua figura, possiamo comprendere quanto le condizioni di vita delle donne nel XVII secolo fossero spietate. La sua storia ci fa interrogare sul prezzo che la società ha imposto, e ancora impone, alle donne che tentano di alzare la voce, che chiedono un cambiamento, che chiedono di poter vivere una vita dignitosa. La sua vicenda ci invita a ricordare che la lotta per i diritti delle donne è lunga, e che ogni piccolo gesto di resistenza, anche quando sembra estrema e disperata, è una forma di resistenza. Giulia Tofana ci insegna che la libertà, spesso, si paga a caro prezzo.
La produzione dell’acqua tofana non cessò dopo la morte di colei che la rese famosa e il suo uso è stato attribuito, tra le altre, alla marchesa de Brinvilliers, nobildonna francese che tra il 1666 e il 1676 ne sperimentò l’efficacia uccidendo numerose persone tra cui il padre e due suoi fratelli mentre, di lì a poco, sarebbe scoppiato nella Francia di Re Sole il cosiddetto affare dei veleni, la cui protagonista principale fu “La Voisin”.


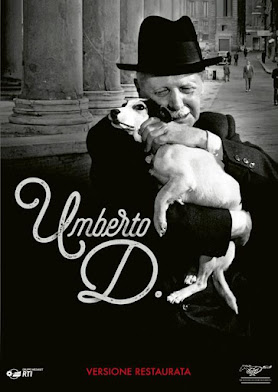


.jpg)



